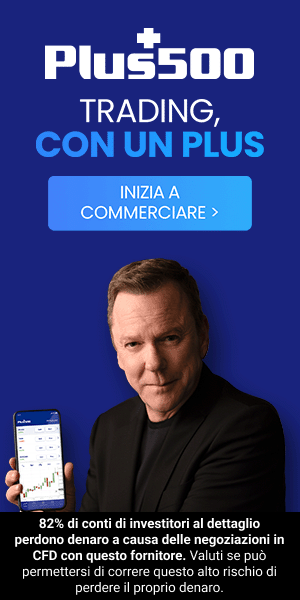I mining pool rappresentano un rischio per le criptovalute e quindi per gli investitori che vi tradano? Il tema sta alimentando una certa discussione a livello internazionale, con vari commentatori che si schierano ora da una parte ora dall’altra. A tal proposito, appare molto interessante la riflessione che Tanzeel Akhtar ha fatto su Investing.com, e che ha cercato di sviscerare l’argomento, dando voce a chi considera i mining pool un pericolo e a chi, invece, tende a ridimensionarlo.
Cosa sono i Mining Pool
I mining pool sono gruppo di miner. Nascono principalmente per due motivi. Il primo, il crescente fabbisogno di potenza di calcolo. Sebbene il riferimento sia principalmente al Bitcoin, che ha raggiunto una esigenza di calcolo pazzesca per poter essere minata con una certa efficacia, ma ciò vale, in varie misure, per tutte le criptovalute. I gruppi di mining assommano “più potenze di calcolo”, proprio perché sono associazioni di soggetti che condividono risorse e introiti. Il secondo motivo risiede nella popolarità che le criptovalute hanno conquistato negli ultimi anni. Tale popolarità ha favorito l’entrata in scena di un gran numero di individui desiderosi di cavalcarne l’onda “lato informatico”, ossia infilandosi nei processi di estrazione.
Attualmente, i mining pool hanno raggiunto un livello di protagonismo piuttosto alto. Aktar riporta un dato molto indicativo a tal proposito: a fine gennaio 2018, quasi quattro quinti del mercato del mining era appannaggio dei mining pool. Ai miner più piccoli, quindi, non rimangono che le briciole. La stessa Akhtar, nel corso dell’articolo, giusto per dare una idea del fenomeno, ha citato i cinque principali miner (facendo riferimento alle parole del CEO di Peppermint Chain, Manish Kumbhare): BTC.com, ViaBTC, AntPool, BTC.TOP, Slushpool.
Questi cinque mining pool possiedono il 65% dell’hash rate. Proprio questo è il dato attorno al quale si incentrano le riflessioni dell’esperta di Investing.com. Cos’è l’hash rate? Il concetto è abbastanza complicato, ma basti sapere che è un indice della potenza di calcolo, il quale va inteso in senso esclusivo: se un player esercita una potenza di calcolo enorme mentre fa mining, gli altri player ne esercitano una minore. Ovviamente, un hash rate alto è un evento piuttosto positivo, in quanto aumenta le probabilità di scovare un nuovo blocco, e quindi di minare la criptovaluta.
Un altro fenomeno decisivo, ai fini della riflessione dell’Akhtar, è la seguente: i miner, specie i miner di Bitcoin, verificano con un certo grado di sicurezza le transazioni e piazzano i blocchi in un ledger decentralizzato.
Perché i Mining Pool sono un pericolo
Akhtar ci tiene a dare spazio a entrambe le campane. Inizia presentano alcuni dei pericoli, o supposti tali, derivanti dalla crescita esponenziale dei mining pool. Il primo rischio, a dire il vero, non riguarda la sicurezza bensì l’immagine che il mondo delle criptovalute vuole dare di sé. Un immagine che, come tutti gli investitori sanno, ha molto a che vedere con il concetto di indipendenza e di decentralizzazione. D’altronde, le criptovalute sono nate per offrire una alternativa al circuito tradizionale, e per farlo hanno dovuto per forza imboccare (con orgoglio) la strada dell’acefalia. Ebbene, il predominio dei mining pool mette a rischio il binomio criptovalute-decentralizzazione. E, a partire da questo dato di fatto, pone in essere rischi per la sicurezza, che è poi il secondo problema affrontato dalla esperta di Investing.com.
Scrive infatti la Akhtar: “I mining pool possono però ridurre o, nei peggiori dei casi, persino bloccare le opportunità per i singoli miner. Aumenta la possibilità di una collaborazione per un attacco di quasi il 51%. Oltre a stravolgere la natura decentralizzata delle criptovalute, uno dei principi cardine della classe di asset, questi pool possono anche insidiare le operazioni minori, alimentando i timori di un attacco del 51%”.
Per inciso, come spiega la stessa Akhtar, gli attacchi del 51% si intendono delle vere e proprie offensive che un player può portare avanti contro una blockchain, sfruttando proprio l’elevato hashrate, che deve essere appunto superiore al 50%. Insomma, se un miner (impossibile) o un gruppo di miner (già più probabile) ha una potenza di calcolo pari al 51% del totale, può potenzialmente violare la blockchain, con tutti i rischi e le conseguenze che è facile immaginare.
Questo, dal punto di vista teorico. La Akhtar ci tiene a precisare che la sua intenzione non è quella di fare allarmismo o, peggio, screditare il mondo delle criptovalute.
Il pericolo, ripetiamolo “dal punto di vista potenziale”, c’è. La pensa così, come riportato nell’articolo di Investing.com, anche Marcon Bernegger, membro del board di Falcon Private Bank e consulente ICO di SwissRealCoin, secondo cui: “I mining pool sono in realtà un argomento interessante. Ma centralizzando i processi si elimina la gran parte di quello che rende tanto affascinanti le criptovalute. A sua volta, ciò espone miner e fan ad un aumento dei problemi legati alla sicurezza, con la conservazione dei dati degli utenti – e delle loro valute – in un unico posto”.
Perché i Mining Pool NON sono un pericolo
Se nella teoria, un attacco del 51% sarebbe nelle disponibilità dei mining pool, nella pratica tutto ciò diventa alquanto difficile. I motivi sono due.
Primo, la quantità non basta, serve anche la costanza. In estrema sintesi, per portare a termine un attacco, non basterebbe avere la maggior parte dell’hashrate (e ovviamente avere cattive intenzione), bisognerebbe mantenere le proporzioni per un tempo sufficientemente lungo da poter fare incetta della blockchain. Per giunta, senza farsi scoprire. Già questo è piuttosto improbabile. Una riflessione di questo tipo appartiene, tra gli altri, a Alexander Demidko, fondatore di Fluence, il cui pensiero è stato riportato con precisione dalla Akhtar. “Chi attacca dovrà non solo ottenere il controllo di oltre il 51% della rete, già difficile di per sé, ma anche sostenere questo controllo abbastanza a lungo da avere l’opportunità [di eseguire] cattive azioni. E tutto senza farsi notare da nessuno”.
Secondo, ai mining pool semplicemente violare la blockchain… Non conviene. O, almeno, non converrebbe. In primo luogo, perché potrebbero farlo solo una volta. Dopo aver violentato una criptovaluta, questa perderebbe di fiducia e allontanerebbe gli investitori. Insomma, non ci sarebbero più polli da spennare. Secondariamente, una violazione della blockchain causerebbe danni agli stessi assaltatori. Questi, ricordiamolo, essendo dei miner, possiedono per definizionare una certa quantità di criptovaluta.
Però, dopo un attacco, cosa accadrebbe? Lo ha spiegato Ryan Taylor, CEO di Dash Core Group. “Se uno degli attaccanti dovesse usare in modo disonesto la propria capacità per riscrivere la cronologia delle transazioni, i partecipanti della rete perderebbero rapidamente la fiducia nella blockchain attaccata. Una perdita di fiducia si tradurrebbe velocemente in cali di prezzo, che eroderebbero i ritorni dei massicci investimenti nelle attrezzature di mining. Dal momento che un attacco del 51% non esenta dal rischio chi attacca, la realtà è che potrebbe non esistere lo scenario in cui un attacco del 51% sia economicamente fattibile per chi attacca”.
Questa riflessione pare mettere fine a qualsiasi timore sui mining pool…. Lato sicurezza. I mining pool qualche conseguenza “oggettiva” per i miner minori la stanno però causando. Per esempio, vista la crescente domanda di “affiliazione”, e quindi di hardware estremamente potente, i produttori hanno fatto schizzare alle stelle i costi delle GPU. Questa dinamica si riflette anche sugli utili dei produttori di chip, che, rileva la Akhtar, sono passati “da 168 milioni di dollari del 2015 a 1,1 miliardi di dollari”.
Un aumento legittimo, che segue le dinamiche della legge della domanda e dell’offerta, ma che certamente è dovuto (in parte) al ruolo sempre più preminente esercitato dai mining pool.